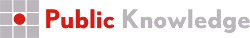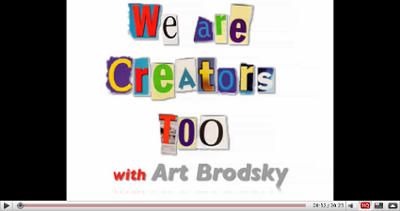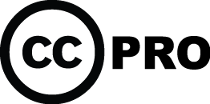(Original article: The Promise of a Post-Copyright World. Translation originally posted at http://it.geocities.com/comedonchisciotte/copyright.html; see also http://eprints.rclis.org/2760/ and http://eprints.rclis.org/2760/3/copyright.html).
La promessa di un mondo senza copyright
di Karl Fogel
La storia del copyright ci spiega come esso sia nato per proteggere un modello di business e non gli interessi degli artisti. E sia stato originato dalla censura.
Un lungo articolo per spiegare come si può arrivare al superamento del concetto di copyright, in un mondo in cui la creatività non sia dominata dal denaro.
L’alternativa è ritornare alla censura.
C’è un gruppo di persone che non sono sorprese dalla recente decisione dell’industria discografica di andare in giudizio contro utilizzatori scelti a caso del file sharing: gli storici del copyright. Essi già sanno ciò che tutti gli altri stanno scoprendo lentamente: che il copyright non ha mai riguardato il pagamento degli artisti per il loro lavoro; il copyright, più che essere pensato per aiutare gli inventori, è stato pensato da e per i distributori – cioè quelli che pubblicano, che oggi comprendono le aziende discografiche. Ma ora che Internet ci ha dato un mondo senza costi di distribuzione, non ha più senso restringere la condivisione delle opere per pagare una distribuzione centralizzata. Non solo è possibile abbandonare il copyright, ma anche desiderabile. Gli artisti e gli utenti ne avrebbero beneficio sia dal punto di vista finanziario che artistico. Invece di coloro che aprono le porte delle aziende e determinano cosa può essere distribuito e cosa no, un meccanismo di selezione più raffinato consentirebbe alle opere di diffondersi solo in base al loro merito. Vedremmo un ritorno alla vecchia e ricca cosmologia della creatività, in cui la libera copia e il prestito delle opere è semplicemente una parte normale del processo creativo, un modo per riconoscere le proprie sorgenti e migliorare in base a ciò che è stato fatto in passato. E la vecchia bufala che gli artisti hanno bisogno del copyright per guadagnarsi da vivere si rivelerebbe per la pretesa che è sempre stata.
Naturalmente niente di tutto ciò succederà se l’industria continuerà il suo corso. L’industria editoriale ha lavorato duramente per tre secoli, per oscurare le vere origini del copyright e per sostenere il mito che esso è stato inventato da scrittori ed artisti. Ancora oggi essa continua la campagna per leggi contro la condivisione più dure, per trattati internazionali che obblighino gli stati ad adeguarsi alle più strette regolamentazioni sul copyright e soprattutto per assicurarsi che il pubblico non chieda mai chi, precisamente, questo sistema vuole favorire.
Il premio a questi sforzi si vede nelle reazioni del pubblico alle condanne per lo scambio di file. Anche se molti concordano che stavolta l’industria si è spinta troppo in là, l’errore viene trattato principalmente come un errore di gradazione – come se le industrie discografiche avessero buone ragioni ma, nel sostenerle, fossero semplicemente ricorse ad un eccesso di forza.
Leggere la vera storia del copyright equivale a capire come questa reazione giochi completamente a favore dell’industria. Le aziende discografiche in realtà non si preoccupano se vinceranno o perderanno i processi. A lungo termine, nemmeno si aspettano di eliminare il file sharing. Ciò per cui esse combattono è molto più grande. Combattono per mantenere uno stato mentale, un’attitudine verso il lavoro creativo, la quale dice che qualcuno deve possedere i prodotti della mente e controllare chi può copiarli. E l’industria ha avuto un successo sorprendente posizionando il tutto come una contesa tra gli Artisti Assediati, che si suppone abbiano bisogno del copyright per pagare l’affitto, e le Masse Irragionevoli, che vorrebbero copiare una storia o una canzone da Internet invece che pagare un prezzo adeguato. Essi sono riusciti a sostituire i termini caricati “pirateria” e “furto” al più preciso “copia” – come se non ci fosse differenza tra rubare la tua bicicletta (adesso tu non hai più la bicicletta) e copiare la tua canzone (adesso tutti e due abbiamo la canzone). Fatto ancora più importante, la propaganda dell’industria ha fatto diventare una credenza comunemente accettata l’idea che il copyright sia il modo in cui la maggior parte dei creatori guadagnano da vivere – che senza copyright i motori della produzione intellettuale si fermerebbero e gli artisti non avrebbero né i mezzi né le motivazioni per produrre nuove opere.
Una visione ravvicinata della storia mostra inoltre che il copyright non è mai stato un fattore importante per consentire la fioritura della creatività. Il copyright è un sottoprodotto della privatizzazione della censura governativa nell’Inghilterra del sedicesimo secolo. Non ci fu alcuna sollevazione di autori che improvvisamente chiedevano il diritto di impedire agli altri di copiare i loro lavori; gli autori, ben lontani dal vedere la copia come furto, generalmente la vedevano come adulazione. La maggior parte del lavoro creativo è sempre dipeso, allora e oggi, da una diversità di fonti di finanziamento: commissioni, lavori d’insegnamento, concessioni o stipendi, patrocinio, etc. L’introduzione del copyright non cambiò questa situazione. Ciò che esso fece fu consentire un particolare modello di business – la stampa di massa con distribuzione centralizzata – per rendere disponibili poche opere fortunate ad un’udienza più ampia, con considerevole profitto dei distributori.
L’arrivo di Internet, con la sua distribuzione istantanea a costo zero, ha reso obsoleto quel modello di business – non soltanto obsoleto, ma un ostacolo a quei grandi benefici che si dichiarava che il copyright dovesse portare in primo luogo alla società. La proibizione al popolo di condividere liberamente informazioni non serve a nessun altro interesse che a quello degli editori. Anche se le industrie vorrebbero farci credere che la proibizione della condivisione è qualcosa che ha a che vedere con il consentire agli artisti di guadagnarsi da vivere, la loro affermazione non regge nemmeno ad un esame superficiale. Per la grande maggioranza degli artisti il copyright non porta alcun beneficio economico. Vero, ci sono poche star – alcuni dei quali con grande talento – le cui opere sono appoggiate dall’industria; essi ricevono la parte del leone dell’investimento in distribuzione e in modo analogo generano il profitto più grande, che viene condiviso con l’artista in termini migliori dell’usuale, perché la posizione contrattuale dell’artista è più forte. In modo per niente incidentale, queste star sono quelli che l’industria sostiene come esempi dei benefici del copyright.
Ma trattare questi piccoli gruppi come rappresentativi vorrebbe dire confondere il marketing con la realtà. La vita della maggior parte degli artisti non appare per niente simile alla loro e mai lo sarà, nell’attuale sistema basato sul profitto. Ecco perché lo stereotipo dell’artista impoverito rimane vivo e vegeto dopo trecento anni.
La campagna dell’industria editoriale per mantenere il copyright è intrisa di puro interesse personale, ma ci forza ad una scelta chiara. Possiamo guardare a come gran parte della nostra eredità culturale viene contenuta in una macchina per vendere e rivenduta a noi dollaro per dollaro – oppure possiamo riesaminare il mito del copyright e trovare un’alternativa.
La prima legge sul copyright fu una legge di censura. Essa non aveva niente a che fare con la protezione dei diritti degli autori, o con il loro incoraggiamento a produrre nuove opere. Nell’Inghilterra del sedicesimo secolo i diritti degli autori non correvano alcun rischio ed il recente arrivo della macchina per stampare (la prima macchina per copiare del mondo) era qualcosa che stimolava gli scrittori. Così stimolante, infatti, che il governo inglese cominciò a preoccuparsi per le
troppe opere che venivano prodotte, non troppo poche. La nuova tecnologia, per la prima volta, stava rendendo ampiamente disponibili letture sediziose ed il governo aveva bisogno urgente di controllare il fiume di materiale stampato, essendo allora la censura una funzione amministrativa legittima come la costruzione di strade.
Il metodo scelto dal governo fu di stabilire una corporazione privata di censori, la London Company of Stationers (Corporazione dei Librai di Londra), i cui profitti sarebbero dipesi da quanto bene essi avrebbero realizzato il proprio lavoro. Agli Stationers fu concesso il diritto su tutta la stampa in Inghilterra, sia per le vecchie opere che per le nuove, come premio per mantenere un occhio stretto su ciò che veniva pubblicato. Il loro documento di concessione diede loro non solo il diritto esclusivo di stampare, ma anche il diritto di cercare e confiscare le stampe ed i libri non autorizzati e addirittura di bruciare i libri stampati illegalmente. Nessun libro poteva essere stampato fino a che non era entrato nel Registro della corporazione e nessun’opera poteva essere aggiunta al registro finché non aveva passato il censore della corona, o era stato auto – censurato dagli Stationers. La Company of Stationers diventò, in effetti, la polizia privata, dedita al profitto, del governo [1].
Il sistema era stato apertamente progettato proprio per servire i venditori di libri ed il governo, non gli autori. I nuovi libri venivano immessi nel registro della corporazione sotto il nome di un membro della corporazione, non sotto il nome dell’autore. Per convenzione, il membro che aveva registrato il libro manteneva il “copyright”, il diritto esclusivo di pubblicare quel libro sugli altri membri della corporazione, e la Court of Assistants della Corporazione risolveva le dispute su eventuali infrazioni [2].
Questa non fu semplicemente una nuova manifestazione di qualche forma di copyright preesistente. Non è come se gli autori avessero avuto precedentemente il copyright, che ora era stato tolto a loro e dato agli Stationers. Il diritto degli Stationers era un nuovo diritto, per quanto fosse basato su una lunga tradizione di concedere i monopoli alle corporazioni, in modo da usarle come mezzo di controllo. Prima di questo momento il copyright – cioè il generico diritto, tenuto privatamente, di proibire agli altri la copia – non esisteva. La gente stampava normalmente, quando aveva la possibilità, le opere che ammirava, un’attività che è responsabile della sopravvivenza di molte di quelle opere fino al giorno d’oggi. Naturalmente si potrebbe proibire la distribuzione di un documento specifico a causa del suo potenziale effetto diffamatorio, o perché esso era una comunicazione privata, o perché il governo lo considera pericoloso e sedizioso. Ma queste sono ragioni di salute pubblica o danno alla reputazione, non di diritto di proprietà. In alcuni casi c’erano stati anche privilegi particolari (allora chiamati “patenti”) che consentivano la stampa esclusiva di certi tipi di libri. Ma fino alla Company of Stationers non c’era stata un’ingiunzione globale contro la stampa in generale, né una concezione del copyright come una proprietà legale che potesse essere posseduta da una parte privata.
Per circa un secolo e mezzo questa associazione funzionò bene per il governo e per gli Stationers. Gli Stationers trassero profitto dal loro monopolio e il governo esercitò il controllo sulla diffusione delle informazioni tramite gli Stationers. Tuttavia, verso la fine del diciassettesimo secolo, a causa di maggiori cambiamenti politici, il governo allentò le sue politiche censorie e fece terminare il monopolio degli Stationers. Ciò significava che la stampa sarebbe dovuta ritornare al proprio stato anarchico precedente e naturalmente fu una minaccia economica ai membri della corporazione, abituati come erano ad avere la licenza esclusiva di produrre libri. La dissoluzione del monopolio avrebbe potuto essere buona per autori a lungo soppressi e stampatori indipendenti, ma essa suonava come un disastro per gli Stationers, ed essi rapidamente elaborarono una strategia per mantenere la loro posizione nel nuovo clima politico liberale.
Gli Stationers basarono la loro strategia su un riconoscimento decisivo, che è rimasto da allora alle aziende editoriali fino a oggi: gli autori non hanno i mezzi per distribuire le proprie opere. Scrivere un libro richiede solo penna, carta e tempo. Ma la distribuzione di un libro richiede presse per la stampa, reti di trasporto ed investimenti iniziali in materiali e macchine compositrici. Così, ragionarono gli Stationers, le persone che scrivono avranno sempre bisogno della collaborazione di un editore per rendere il loro lavoro disponibile alla generalità. La loro strategia usò questo fatto fino al massimo vantaggio. Essi andarono in Parlamento e fornirono l’argomento, basato sulla storiella-di-allora, che gli autori avevano un inerente diritto di proprietà naturale su ciò che scrivevano e che inoltre questa proprietà poteva essere trasferita ad altre parti per contratto, come ogni altra forma di proprietà.
Il loro argomento riuscì a convincere il Parlamento. Gli Stationers avevano fatto in modo da evitare l’odio verso la censura, poiché i nuovi diritti di riproduzione avrebbero avuto origine dall’autore, ma essi sapevano che gli autori avrebbero avuto ben poche possibilità di scelta oltre che firmare per trasferire questi diritti ad un editore per la pubblicazione. Ci fu qualche disputa giudiziaria e politica sui dettagli, ma alla fine tutte e due le metà dell’argomento degli Stationers sopravvissero essenzialmente intatte e diventarono parte della statutory law inglese. Il primo copyright riconoscibilmente moderno, lo Statute of Anne (Statuto di Anna) fu approvato nel 1710.
Lo Statuto di Anna viene spesso richiamato dai campioni del copyright come il momento in cui gli autori ricevettero finalmente la protezione che essi meritavano da tempo. Ancora oggi esso viene referenziato, sia in argomentazioni legali che in stampati dell’industria editoriale. Ma interpretarlo come una vittoria degli autori contrasta sia con il comune buon senso che con i fatti storici [3]. Gli autori, che non avevano avuto il copyright, non vedevano nessuna ragione di chiedere improvvisamente il potere piuttosto paradossale di evitare la diffusione delle proprie opere, e non lo fecero. Le sole persone preoccupate della dissoluzione del monopolio degli Stationers erano gli Stationer stessi, e lo Statuto di Anna fu il diretto risultato della loro campagna di lobbying.
Nelle memorabili parole del contemporaneo Lord Camden, gli Stationers “…vennero in Parlamento come supplicanti, con le lacrime agli occhi, infelici e sfiduciati; essi portarono con sé mogli e bambini per provocare compassione e indurre il Parlamento a garantire loro una sicurezza legale.” [4] Per rendere più appetibili i loro argomenti, essi avevano proposto che il copyright fosse originato dall’autore, come una forma di proprietà che poteva essere venduta a chiunque – aspettandosi correttamente che il diritto sarebbe stato venduto quasi sempre ad un editore.
Questa proposta fu un’astuta mossa tattica, perché il Parlamento voleva impedire il ristabilimento di un monopolio centralizzato nel commercio dei libri, con la sua potenzialità di un ripristino della censura da parte della Corona. Benjamin Kaplan, professore di legge emerito all’università di Harvard e rispettato studioso del copyright, descrive brevemente la posizione degli Stationers:
… gli Stationers fecero il caso che essi non potessero produrre quei fragili prodotti detti libri e così incoraggiare gli uomini istruiti a scriverli, senza una protezione contro la pirateria… C’è un apparente tracciato dei diritti verso una fonte ultima nel fatto della proprietà intellettuale, ma prima di dare a ciò grande importanza dobbiamo osservare che, se la stampa come commercio non fosse messa nuovamente nelle mani di pochi monopolisti, — se lo statuto venisse ad essere effettivamente una specie di “patente universale” — un legislatore sarebbe condotto naturalmente esprimersi in termini di diritti nei libri e quindi di diritti iniziali negli autori. Un legislatore sarebbe comunque consapevole che i diritti di solito passerebbero immediatamente agli editori per assegnazione, cioè dall’acquisto dei manoscritti come nel passato… Penso sia più vicino alla verità dire che gli editori videro il vantaggio tattico di proporre gli interessi degli autori insieme ai propri e questa tattica produsse un certo effetto sul tono dello statuto.[5]
Lo statuto di Anne, preso nel contesto storico, è la pistola fumante della legge sul copyright. In esso possiamo vedere l’intero apparato del copyright moderno, ma ancora in forma indistinta. C’è la nozione del copyright come proprietà, come pure la proprietà intesa realmente per gli editori, non per gli autori. C’è la nozione della società che ne beneficia, incoraggiando la gente a scrivere i libri, ma nessuna evidenza viene offerta per mostrare che la gente non scriverebbe libri in assenza copyright. La discussione degli Stationers fu piuttosto che gli editori non potrebbero permettersi di stampare libri senza una protezione dalla concorrenza e che gli autori produrrebbero poche opere nuove senza un’aspettativa di distribuzione. Questo [argomento] non era del tutto in malafede; le corti ed il Parlamento non sarebbero stati così favorevoli se effettivamente fosse stato del tutto incoerente. Gli editori furono ora efficacemente costretti a pagare gli autori in cambio dei diritti esclusivi di stampa (sebbene in effetti gli Stationers a volte avessero pagato gli autori anche prima, semplicemente per garantirsi il completamento e la consegna di un’opera). Gli autori che riuscirono a vendere questo nuovo diritto agli stampatori non ebbero particolari motivi di lamentarsi — e naturalmente, non si sente parlare molto degli autori sfavoriti. Il consolidamento del copyright dell’autore probabilmente contribuì al declino del patronato come fonte di reddito per gli scrittori [6] e ad alcuni autori consentì perfino, benché sempre una piccola minoranza, di sostenersi solamente dai diritti d’autore che i loro editori dividevano con loro.
Ma la testimonianza storica globale è chiara: il copyright fu progettato dai distributori per sovvenzionare se stessi, non i creatori.
Questo è il segreto che l’odierna lobby del copyright non ha mai il coraggio di dire ad alta voce, perché una volta che venisse ammesso, diventerebbe chiaro in modo imbarazzante il vero scopo della successiva legislazione sul copyright. Lo statuto di Anne fu semplicemente l’inizio.
Assegnando la premessa che il copyright debba esistere, il governo inglese si trovò sotto pressione per estendere sempre di più i termini del copyright. Nella lunga saga legale che seguì, non è importante la particolare sequenza di leggi e verdetti, ma l’identità dei querelanti: essi erano proprio il tipo di interesse affaristico stabile e consolidato, capace di sostenere la controversia e di fare pressioni per decenni — erano cioè editori, non autori. Avevano proposto il copyright dell’autore per interesse economico e solo dopo che la stampella di un monopolio basato sulla censura era stato tolto a loro. Quando fu evidente che la tattica funzionava, essi spinsero per rinforzare il copyright.
Il modello è questo ancora oggi. Ogni volta che il congresso degli USA estende i termini o la portata del copyright, ciò è il risultato di pressioni dell’industria editoriale. A volte, i gruppi di pressione metteranno in mostra un autore o un musicista superstar, una faccia umana per quello che è essenzialmente uno sforzo dell’industria, ma è sempre molto chiaro cosa sta accadendo in realtà. Tutto ciò che dovete fare è guardare chi sta pagando le fatture degli avvocati e dei gruppi di pressione, il cui nome compare nei registri delle sentenze della corte — gli editori.
Tuttavia la campagna secolare dell’industria per una forte legge sul copyright non è semplicemente avidità riflessa. È una naturale risposta economica alle circostanze tecnologiche. L’effetto del torchio tipografico e successivamente della tecnologia di registrazione analogica del suono, avrebbe reso le opere dell’ingegno inseparabili dai mezzi per la loro distribuzione. Gli autori avevano bisogno degli editori come l’elettricità ha bisogno dei fili. L’unico metodo economicamente praticabile per raggiungere i lettori (o gli ascoltatori) era la stampa di massa: produrre insieme migliaia di copie identiche, poi spedirle fisicamente ai vari punti di distribuzione. Naturalmente ogni editore, prima di accettare un tale investimento, preferisce comprare o prendere in leasing il copyright dall’autore, proprio come naturalmente incita il governo ad estensioni più forti possibili del copyright, il meglio per proteggere il suo investimento.
In questo non c’è niente di intrinsecamente strumentale; è pura economia. Dal punto di vista degli affari, il funzionamento della stampa è un progetto rischioso e scoraggiante. Comporta alti costi iniziali del supporto fisico (sia esso la polpa dell’albero, nastro magnetico, dischi in vinile, o dischi ottici incisi), oltre a macchinari complessi e costosi per stampare il contenuto sul supporto. Inoltre c’è l’investimento occulto del controllo della copia matrice: poiché un master difettoso può ridurre il valore di tutto il lavoro, gli editori e gli autori incontrano considerevole difficoltà per generare una versione del lavoro pulita e priva di errori prima della stampa. Qui c’è poco spazio per un processo incrementale o evolutivo; il lavoro deve essere reso quasi perfetto prima che il pubblico possa vederlo. Se degli errori sono trascurati, dovranno essere tollerati nel prodotto finito, almeno fino al riavvio del processo per la ristampa successiva. L’editore deve anche negoziare i prezzi ed allineare i percorsi di distribuzione, che è non soltanto un problema di contabilità, ma di spese fisiche, di camion e treni e contenitori per trasporto. Infine, come se tutto questo non fosse abbastanza, l’editore è costretto a spendere ulteriore denaro per il marketing e la pubblicità, per avere una migliore possibilità di recuperare almeno tutte le spese.
Quando ci si rende conto che tutto questo deve accadere prima che l’opera generi un penny di reddito, è poco sorprendente che gli editori sostengano fortemente il copyright. In termini economici, l’investimento iniziale degli editori in ogni opera individuale – cioè il loro rischio – è più grande di quello dell’autore. Gli autori in sé non avrebbero desiderio intrinseco di controllare la copiatura, ma gli editori lo hanno. Naturalmente gli autori hanno tanto più bisogno degli editori in un mondo si è riempito di reparti di marketing sostenuti dalle royalty degli editori. La concentrazione dei redditi di distribuzione provoca inevitabilmente la logica familiare di una corsa agli armamenti.
L’arrivo di Internet ha profondamente cambiato questa equazione. Ormai é divenuto un cliché affermare, come in realtà è, che Internet ha portato uno sviluppo rivoluzionario così come lo è stato l’arrivo della stampa. Ma internet è rivoluzionaria in modo diverso. La stampa rese possibile la produzione di molteplici copie a partire da un libro, ma tali copie dovevano essere ancora fisicamente trasportate dalla tipografia alle mani dei lettori. Dal punto di vista fisico, il libro non era solo il modo con il quale accedere al suo contenuto, ma costituiva anche il mezzo per recapitare il suo contenuto ai consumatori. Le spese totali sostenute degli editori erano quindi praticamente proporzionali al numero di copie distribuite. In tale situazione è ragionevole chiedere che ciascun consumatore contribuisca ad una parte dei costi di distribuzione, tenuto conto che dopo tutto ciascun utente è più o meno responsabile dei costi che hanno fatto pervenire il libro nelle sue mani. Se il libro (o il disco) è nelle sue mani, deve averlo preso da qualche parte e qualcuno deve aver speso dei soldi per farlo arrivare li. Dividete queste spese per il numero di copie, aggiungete un certo margine di profitto e arrivate in linea di massima al prezzo del libro.
Oggi, però, il mezzo su cui vengono distribuiti i contenuti può essere del tutto diverso da quello utilizzato al momento della fruizione ultima del contenuto. I dati possono essere trasmessi su cavo a costo essenzialmente zero e l’utente, che si trova dall’altra parte del cavo, può stampare la copia di un’opera a proprie spese e con la qualità che può permettersi [7]. Ne consegue che la pratica di applicare un ricarico fisso su ogni copia, indipendentemente dal numero di copie distribuite, ha poco senso, in quanto il costo di produzione e distribuzione di un lavoro è essenzialmente fisso e non più collegato al numero di copie. Dal punto di vista della società, ogni dollaro in più speso oltre a quelli necessari (se ce ne sono) per far emergere un lavoro è in primo luogo uno spreco e costituisce un impedimento alla capacità del lavoro di diffondersi in base ai propri meriti.
Internet ha fatto qualcosa che la compagnia degli Stationers non aveva previsto: ha reso gli argomenti della loro discussione un’ipotesi verificabile. Gli autori continuerebbero a creare, senza una struttura centralizzata che distribuisca le loro opere? Una conoscenza anche minima di Internet è sufficiente per fornire la risposta: ovviamente si, lo stanno già facendo. Gli utenti dei computer scaricano comodamente musica e realizzano CD a casa e, lentamente ma inevitabilmente, i musicisti immettono comodamente in rete nuovi brani “free” pronti per essere scaricati [8]. Anche alcuni lavori brevi come romanzi e non solo sono disponibili on-line.
Sebbene sia vero che la stampa e la rilegatura su richiesta di interi libri siano ancora rare, questo avviene solo perché le macchine necessarie sono ancora abbastanza costose. Comunque le apparecchiature diventano sempre più economiche ed è solo una questione di tempo prima che la copisteria sotto casa le abbia a disposizione. Da un punto di vista della distribuzione non vi è differenza tra testo e musica e appena la tecnologia per la stampa e la rilegatura diverrà più economica, gli autori di libri vedranno molto più chiaramente che essi hanno le stesse alternative di cui dispongono nell’immediato i musicisti, e il risultato sarà lo stesso: sempre più materiale disponibile senza restrizioni, a partire dalla scelta dell’autore.
Alcuni possono argomentare che gli autori sono differenti e che essi sono molto più dipendenti dal copyright di quanto lo siano i musicisti. Dopo tutto un musicista fa dei concerti e può quindi guadagnare indirettamente da una distribuzione libera dei propri brani – la maggiore diffusione delle proprie canzoni permette di effettuare maggiori concerti. Gli autori però non fanno rappresentazioni; raggiungono il loro pubblico attraverso le opere e non di persona. Se ora volessero trovare dei modi per auto-finanziarsi senza imporre una scarsità di risorse ai loro lavori, potrebbero farlo?
Immaginate lo scenario più semplice: entrate nella libreria di quartiere e fornite ad un impiegato l’indirizzo web del libro che state cercando. Un paio di minuti dopo, l’impiegato ritorna con una copia fresca del libro scaricata da internet, appena stampata e rilegata, ed annuncia il prezzo:
“Sono otto dollari. Vuole aggiungere la donazione di un dollaro per l’autore?”
Accettate? Ovviamente potete dire si o dire no, ma si deve notare che quando i musei propongono una donazione volontaria la gente di solito paga. Una cosa del tutto simile potrebbe quindi accadere nella libreria. Molte persone sono contente di pagare un piccolo extra su una spesa abbastanza grande se hanno tirato fuori il portafogli e pensano che sia per una buona causa. Quando le persone rinunciano a fare una piccola donazione volontaria per una causa in cui credono, è più spesso a causa di inconvenienti (scrivere un assegno, spedirlo, ecc) che a causa dei soldi. Ma se anche solo la metà, o meno, di tutti i lettori facesse tale donazione, gli autori guadagnerebbero tranquillamente più di quanto guadagnano con il sistema tradizionale delle royalty ed avrebbero inoltre il piacere di divenire finalmente gli alleati dei lettori e non i loro nemici.
Ovviamente questo non è il solo sistema possibile, anzi può facilmente coesistere con altri sistemi. Quelli che non sono convinti dal meccanismo della donazione volontaria, dovrebbero considerare un altro metodo: il sistema di soglia di garanzia. Questo sistema è stato ideato per risolvere il problema classico dei fondi distribuiti, in cui ogni contribuente vuole essere rassicurato del fatto che tutti i partecipanti al fondo stiano contribuendo, prima di versare i propri soldi. Con il sistema di soglia di garanzia, il promettente autore di una nuova opera comunica in anticipo quanti soldi saranno necessari per la realizzazione dell’opera; questi soldi costituiscono la “soglia”. Un’organizzazione intermediaria, quindi, raccoglie le garanzie con diversi importi, dal grande pubblico. Quando il totale delle garanzie raggiunge la “soglia” (o eccede rispetto alla “soglia” di una qualche percentuale prefissata per tenere la contabilità e per l’assunzione di rischio), l’intermediario stipula con l’autore un contratto in cui vengono inserite le garanzie raccolte. Solo in questo fase, quando ci sono i soldi per raggiungere lo scopo desiderato, a ciascuno viene chiesto il pagamento della quota di garanzia. L’intermediario tiene impegnati i soldi, pagando l’autore secondo una scaletta con esso stabilita nella fase di negoziazione del contratto. Il resto dei soldi verrà pagato quando il lavoro sarà completato e reso pubblicamente disponibile non solo ai contribuenti del fondo ma in generale a chiunque. Se l’autore non conclude il lavoro, l’intermediario restituisce i soldi ai contribuenti del fondo.
Il sistema di soglia garantita possiede alcune caratteristiche interessanti, non riscontrabili nel mercato monopolistico basato sul copyright. Il lavoro di un autore risulta disponibile gratuitamente a chiunque in tutto il mondo. E ancora, l’autore è stato pagato abbastanza per produrre il lavoro: se avesse avuto bisogno di più soldi avrebbe potuto chiederli e restare a vedere se il mercato era disposto a finanziarlo. Quelli che hanno scelto di aderire al fondo, hanno pagato ciò che hanno ritenuto accettabile e niente di più. E infine, non c’erano rischi per i contribuenti in quanto se la “soglia” non fosse stata mai raggiunta nessuno avrebbe pagato alcunché.
Naturalmente non tutti i metodi sono così piacevolmente ispirati da nobili sentimenti. Un paio di anni fa la famosa e affermata autrice Fay Weldon accettò soldi da Bulgari per scrivere un romanzo in cui venivano descritti e messi in evidenza i prodotti di Bulgari. Il libro fu intitolato “The Bulgari Connection” ed era originariamente pensato per una edizione limitata distribuita per una funzione corporativa, ma la Weldon avendo scritto il romanzo, pensò bene di consegnare il romanzo al suo editore per una distribuzione generale. Questo significa che in futuro dovremo esaminare tutte le opere creative per individuare sponsorizzazioni nascoste di eventuali corporazioni? Forse, ma non ci sarebbe niente di nuovo – la messa a disposizione di un prodotto è stata inventata nel tradizionale contesto del copyright ed è li che è fiorita. Il copyright non è né la causa della sponsorizzazione corporativa né il suo antidoto. Sarebbe sorprendentemente fuori luogo il guardare all’industria editoriale come una forza per la de-commercializzazione.
Questi sono alcuni esempi su come sostenere il lavoro creativo senza il copyright. Ci sono molti altri metodi [9]; ce n’erano molti anche prima che Internet rendesse possibile il pagamento e l’acquisto diretto on-line. Non importa se un dato artista usa questo o quel metodo. La cosa importante è che con poca o nessuna difficoltà che impedisca il pagamento di piccole somme, gli autori trovino il modo per far si che tali pagamenti possano avvenire sulla base delle loro esigenze. Gli economisti amanti del mercato come la soluzione a qualunque cosa, dovrebbero innamorarsi di queste possibilità (ma, prevedibilmente, molti di essi non lo sono, poiché odiano vedere qualcosa diventare privo di proprietà).
Per vedere qualche spiraglio del futuro può essere più utile guardare non ai musicisti di buonsenso dediti al guadagno, ma al software. Probabilmente oggi il fiorente movimento del Software Libero è il miglior esempio di un mondo che ha superato il copyright. Il Software Libero (alcuni lo chiamano anche “Open Source” – codice sorgente aperto) è figlio della mente di Richard Stallman, un programmatore che ebbe l’idea di rilasciare il software sotto un copyright deliberatamente invertito. Invece di proibire la condivisione, la licenza software la permette e l’incoraggia. Presto molti altri aderirono a quest’idea e siccome essi riuscirono a condividere e modificare senza limiti ognuno i programmi degli altri, produssero rapidamente una gran quantità di codice funzionante.
Alcuni predissero che il successo iniziale si sarebbe rapidamente appiattito, perché l’aumento di dimensioni e di complessità del software richiedeva un’organizzazione gerarchica e centralizzata per la manutenzione. Ma, invece di affondare, il movimento del Software Libero è cresciuto così rapidamente da sorprendere anche i suoi partecipanti, e non mostra alcun segno di volersi fermare. Oggi esso produce software le cui funzionalità competono con quelle disponibili nel mercato proprietario. Il software Libero è ampiamente usato da banche, aziende e governi, come pure da utenti individuali di computer. Ci sono più siti web basati sul web server libero Apache di quanti siano (tutti insieme) i siti basati su tutti gli altri web server. I sistemi operativi liberi sono ora il segmento in sviluppo più rapido del mercato dei sistemi operativi. Sebbene alcuni autori di software libero siano pagati per il loro lavoro (tutto sommato, il loro servizio ha fornito un beneficio a quelli che usano il software ed alcuni degli utenti vogliono pagare per esso) gli altri hanno offerto il loro tempo volontariamente. Ogni progetto software ha le sue ragioni per esistere ed ogni programmatore ha i suoi motivi per contribuire. Ma l’effetto cumulativo è uno sfoggio diretto dell’intera giustificazione del copyright: esiste una prospera comunità di proprietà intellettuale che non applica il copyright, inoltre essa raggiunge sostanzialmente gli stessi risultati della controparte tradizionale (mainstream).
Secondo la tradizionale giustificazione del copyright, ciò non sarebbe potuto succedere. Il software è essenzialmente di dominio pubblico; il suo copyright serve principalmente ad identificare l’autore originale e, in alcuni casi, ad impedire che qualcun altro imponga una licenza più restrittiva. L’autore ha abbandonato ogni diritto esclusivo, tranne il diritto di essere identificato come l’autore.
Essi sono volontariamente ritornati al mondo precedente alla legge sul copyright: essi impongono che non ci siano royalties e non hanno alcun controllo sulla distribuzione e sulle modifiche del proprio lavoro. La licenza software dà a chiunque il permesso automatico di usarlo e redistribuirlo. Si possono dare ad altri delle copie senza bisogno di informare o chiedere il permesso ad alcuno. Se vuoi modificarlo, sei libero di farlo. Puoi anche venderlo, sebbene sia naturalmente difficile ricaricare molto, perché saresti in competizione con altri che forniscono gli stessi beni senza alcun costo. Un modello più comune è di incoraggiare la gente a scaricare gratuitamente il software e vendere invece servizi, come supporto tecnico, addestramento e personalizzazione. Questi modelli non sono fantasie, essi sono la base per affari proficui che esistono proprio adesso, pagando a programmatori reali salari competitivi per lavorare su software libero. Ma il punto non è che la gente è pagata per farlo – alcuni sono pagati, ma molti altri non lo sono, e comunque scrivono software. Il vero punto è che ogni anno viene prodotta e mantenuta una tremenda quantità di software libero, ad un ritmo che cresce rapidamente anche rispetto agli standard dell’industria del software.
Se questo fenomeno fosse confinato al software, esso sarebbe spiegabile come un’aberrazione – il software è diverso, i programmatori sono sovrapagati e così via. Ma non è solo il software; se guardate con attenzione ci sono segni che ciò sta avvenendo dovunque. I musicisti cominciano a rendere le loro canzoni disponibili per lo scaricamento gratuito e la quantità di scritti liberamente disponibili su Internet – a partire da opere di consultazione e saggistica, ma comprendendo ora narrativa e poesia – ha da lungo tempo superato il punto di misurabilità. Il software non è fondamentalmente diverso da queste altre forme di informazione. Esso può essere trasmesso in forma digitale come i poemi, le canzoni, i libri ed i film. Esso può essere copiato per intero o in parte; può essere citato per l’uso in altre opere; può essere modificato ed editato; può anche essere satireggiato.
Nel software l’abbandono del copyright è avvenuto molto prima, principalmente perché i programmatori sono stati il primo gruppo ad avere accesso ad Internet, non perché ci sia qualcosa di speciale nella natura del software. Nelle altre aree i creatori stanno gradualmente comprendendo che anch’essi possono diffondere le loro opere, senza editori o catene di distribuzione centralizzate, semplicemente consentendo la libertà di copia. Ed essi stanno scegliendo in modo crescente di farlo, perché hanno poco da perdere e perché questa è la via più facile per trovare un uditorio che apprezzi. Lontani dall’essere particolarmente dipendenti dalla legge sul copyright, i creatori guadagnano il massimo quando abbandonano il monopolio del copyright.
Già nei primi stadi di questi andamenti, sorge una domanda ovvia. Se il copyright in realtà non serve a stimolare il lavoro creativo, allora oggi quale scopo ha? Perché è chiaro che, se il copyright non esistesse, noi oggi non lo inventeremmo. Abbiamo appena finito di costruire una gigantesca macchina per copiare (Internet) che fa anche da dispositivo di comunicazione ed incidentalmente rende conveniente il trasferimento di piccole quantità di denaro tra le persone. La condivisione è oggi la cosa più naturale del mondo. L’idea che gli artisti siano in qualche modo preoccupati da essa si dimostra falsa ogni giorno, dalle migliaia di nuove opere che appaiono on-line, firmate e totalmente riconosciute dai loro autori, eppure libere di essere copiate. Se qualcuno volesse argomentare che presto la creatività si seccherà se non istituiamo immediatamente uno stretto sistema di controllo su chi può copiare cosa, noi lo potremmo ragionevolmente guardare come malato. Ancora, in linguaggio leggermente più diplomatico, questo essenzialmente è l’argomento usato dalla lobby del copyright quando preme per leggi sempre più dure.
Qui non è in gioco la creatività e nei suoi momenti più onesti l’industria editoriale lo ammette, anche se implicitamente. Sebbene i leader delle industrie facciano, per relazioni pubbliche, dichiarazioni simboliche sulla necessità di guadagnarsi da vivere dei poveri artisti, le loro dichiarazioni più dettagliate e pressanti riguardano di solito gli effetti del copyright sul business. Larry Kenswil, dello Universal Music Group, la più grande azienda discografica del mondo, citato nel New York Times del 5 gennaio 2003 in un articolo sugli schemi di protezione digitale anticopia, diceva “Voi non comprate musica, voi comprate una chiave. Questo è ciò che fa la gestione digitale dei diritti: consente dei modelli di business.”
E’ difficile immaginare una dichiarazione più sintetica del credo dell’industria. Avrebbe potuto dire allo stesso modo: “Questo è ciò che fa il copyright: consente dei modelli di business.”
Sfortunatamente, non tutta la propaganda prodotta dall’industria è lineare ed onesta come le parole di Kenswil. La Recording Industry Association of America, per esempio, spiega il copyright in questo modo, sul suo sito http://www.riaa.org:
Non c’è bisogno di essere un avvocato per fare il musicista, ma bisogna conoscere un termine legale — copyright. Questo termine interessa intensamente tutti gli artisti creativi — poeti, pittori, romanzieri, ballerini, registi, attori, musicisti e compositori.
Per tutti gli artisti “copyright” è più di un termine della legge sulla proprietà intellettuale, che proibisce la duplicazione, esecuzione o distribuzione non autorizzate di un lavoro creativo. Per essi il termine “copyright” significa la possibilità di affinare la propria arte, sperimentare, creare e prosperare. E’ un diritto vitale e gli artisti hanno combattuto nei secoli per mantenere questo diritto; artisti come John Milton, William Hogarth, Mark Twain e Charles Dickens. Twain andò in Inghilterra per proteggere i suoi diritti e Dickens venne in America per fare la stessa cosa.
La riconoscete? E’ direttamente una pagina dal manuale degli Stationers – una ripetizione senza maschera del mito del copyright, completata con riferimenti a singoli autori, pensati per stimolare il nostro supporto agli artisti che combattono coraggiosamente per la loro integrità artistica. A quanto sembra, per quello che riguarda la RIAA, tutti gli artisti che, nel corso della storia, riuscirono bene senza copyright non sono inclusi tra “tutti gli artisti creativi”. I commenti del professor Patterson riguardo al simile uso che fecero gli Stationers del diritto d’autore come una falsa traccia davanti al Parlamento inglese del sedicesimo secolo, sono applicabili nello stesso modo oggi:
“Essi [gli Stationers] lo fecero con argomenti intesi a suscitare simpatia per l’autore (ignorando convenientemente il loro ruolo nel creare la misera condizione dell’autore che essi piangevano) ed evitando logica e razionalità nel parlare.” [10].
Il paragrafo successivo dell’introduzione della RIAA al copyright è anche peggio. Esso è una breve – molto breve – introduzione alle origini della legge sul copyright, pesante nella cadenza dell’inevitabilità storica, ma piuttosto slegato dai fatti:
L’intera legge sul copyright cominciò con lo “Statuto di Anna”, la prima legge al mondo sul copyright, approvata dal Parlamento inglese nel 1709. Ma il principio di proteggere i diritti degli artisti è precedente. A prima vista potrebbe suonare come cruda storia, ma poiché c’era da stabilire un precedente e diritti da proteggere, molto tempo, molti sforzi e molto denaro sono stati spesi in battaglie legali nel corso dei secoli.
Questo riassunto soffocante è l’equivalente per il copyright di “Cristoforo Colombo partì per l’America per dimostrare che la terra era rotonda e si fece amico con gli Indiani”. Molto denaro è stato speso in battaglie legali, ma la RIAA fa attenzione a non dire chi l’ha speso, né ci sono ulteriori dettagli sul “principio di proteggere i diritti degli artisti” che si vorrebbe far credere che venga prima di questi sviluppi.
Il resto della loro pagina continua con vena analoga, con tante omissioni, errate caratterizzazioni e complete bugie, che è difficile immaginare come possa averla scritta uno che abbia fatto un minimo di ricerche. Essa fondamentalmente è propaganda di basso livello, che supporta la loro continua campagna per convincere il pubblico che il copyright è fondamentale per la civiltà quanto le leggi della termodinamica.
La RIAA indulge pure in una delle tattiche favorite della moderna lobby del copyright: equiparare la copia illegale al reato di plagio, che non è correlato ad essa ed è molto più grave. Per esempio Hilary Rosen, ex capo della RIAA, usava parlare nelle scuole e nelle università, esortando gli studenti ad adottare il punto di vista dell’industria riguardo alla proprietà intellettuale. Qui c’è la sua descrizione di come lei presenta il caso:
Le analogie sono ciò che funziona meglio. Io chiedo a loro: “Cosa avete fatto la settimana scorsa?” Essi possono rispondere di aver scritto un saggio su questo o quell’argomento. Così io domando loro “Così avete scritto un saggio; avete preso un [voto] A? Vi darebbe fastidio se qualcuno potesse prendere quel lavoro e prendere anch’esso un A? Vi farebbe irritare?” Così questo senso di investimento personale suona vero alle persone.
Siccome normalmente le persone che duplicano CD non sostituiscono il loro nome a quello dell’artista, domandiamoci cosa sarebbe successo se Hilary Rosen avesse chiesto: “Vi darebbe fastidio se qualcuno avesse fatto una copia del vostro lavoro, in modo che altri possano trarre beneficio da ciò che avete scritto e vedere che voi avete preso un A?” Naturalmente gli studenti avrebbero risposto: “No, non ci dà per niente fastidio ” il che non è ciò che Rosen voleva udire.
La RIAA è estrema solo nella goffaggine della sua propaganda. In sostanza il suo è lo stesso messaggio che viene offerto dal resto dell’industria del copyright, che mantiene un continuo rullio di tamburi tramite allarmi sullo scambio di contenuti on-line, che priverebbe i creatori della loro reputazione e della loro capacità di lavorare, nonostante la superiore evidenza che, ad ogni modo, il copyright non ha mai fornito loro molto di ciò che serve a vivere e che essi continuerebbero felicemente a creare senza copyright, se avessero a disposizione un modo per distribuire la proprie opere. La campagna suonerebbe dannosa o stupida se venisse descritta come io ho fatto qui, ma siccome essi lottano per la propria sopravvivenza, con grandi somme di denaro a disposizione ed abili uffici di pubblicità, gli editori sono riusciti a formare l’opinione pubblica in modo sorprendente.
Considerate questa povera donna, dall’International Herald Tribune dell’11 settembre 2003, in un articolo sulle condanne della RIAA per condivisione di file:
Una donna che aveva ricevuto una multa dalla RIAA disse che si struggeva per spiegare al figlio di 13 anni perché il file sharing fosse sbagliato. La madre, che evitò di dire il proprio nome a causa della sua situazione legale, aveva detto al figlio “Supponi di aver scritto una canzone ed un famoso gruppo rock l’abbia suonata senza pagarti”. Il figlio aveva risposto “Non me ne preoccuperei. La cosa non avrebbe importanza”. Concludeva la madre: “Essi sono in quella giovane età in cui il denaro non ha importanza.”
La madre raccontò di aver avuto risultati migliori quando aveva confrontato il prendere canzoni di altri al copiare un compito di scuola.
(Speriamo che il sensibile ragazzo di 13 anni riesca a mantenere la sua testa, visto che intorno a lui sembra che molti la stiano perdendo.)
Sfortunatamente la combinazione di un pubblico ancora ben disposto e di tasche piene ha consentito all’industria del copyright di esercitare la sua influenza a livello legislativo. Il risultato è una tendenza deprimente: barriere fisiche e legali che si rinforzano a vicenda e che, pur visibilmente progettate per combattere le copie illegali, hanno l’inevitabile effetto di interferire con tutte le copie. Gli schemi di protezione digitale anticopia sono continuamente rinforzati anche dallo stesso hardware dei vostri computer, piuttosto che tramite un programma malleabile e sostituibile. E le stesse aziende proprietarie dei contenuti spesso producono l’hardware che rende possibile la distribuzione. Avete comprato un computer dalla Sony? Che ne pensate di un CD della divisione musicale della Sony? E’ la stessa azienda e la sua mano sinistra sa cosa fa la mano destra. Con la collaborazione del governo questa combinazione diventa ancora più potente. Adesso negli USA abbiamo una legge – la Digital Millennium Copyright Act – che rende illegale aggirare uno schema di protezione digitale, come pure produrre del software che aiuta gli altri ad aggirare uno schema di protezione digitale. Sfortunatamente, siccome molto hardware e software imprimono automaticamente tali schemi su tutti i [supporti ] dei media che producono, la legge strangola la copia autorizzata e molte altre attività che, in base all’attuale legge sul copyright, ricadrebbero altrimenti nella categoria del “fair use” (uso personale).
È vitale capire come questi side effects (effetti collaterali) non siano né incidenti, né conseguenze inaspettate di uno sforzo benintenzionato per proteggere gli artisti. Essi sono piuttosto parte integrante di una strategia che, alla base, non ha niente a che vedere con l’incoraggiamento alla creatività. Lo scopo di questo sforzo industriale su tre rami – la campagna pubblicitaria, la campagna legale e le “protezioni” hardware – è semplicemente di impedire all’esperimento Internet di giungere a compimento. Ogni organizzazione che sia profondamente coinvolta nei concetti della proprietà intellettuale e del controllo delle copie non può essere contenta se nasce un sistema che rende il copiare facile come un click del mouse. Fino ad ogni limite possibile, queste organizzazioni vorranno continuare il modello in cui si paga per ogni copia (pay-per-copy), che abbiamo usato per secoli, anche se le basi fisiche dell’informazione sono tanto cambiate da renderlo obsoleto.
Sebbene la lobby del copyright riesca a far passare nuove leggi ed anche a vincere alcuni casi in tribunale, queste vittorie si basano su fondamenta che si stanno disintegrando. Per quanto tempo il pubblico continuerà a credere al mito del copyright, alla nozione che il copyright fu inventato per rendere possibile il lavoro creativo? Il mito è stato mantenibile così a lungo perché aveva un granello di verità: sebbene il copyright non fosse ispirato dagli autori e non fosse stato decretato per proteggerli, esso aveva consentito la distribuzione ampia di molte opere originali. Inoltre ci sono molti editori (generalmente i più piccoli o di singoli individui) che si comportano con un ammirevole senso di servizio, aiutando le opere importanti ma non redditizie con il denaro guadagnato dai forti venditori, a volte anche perdendo denaro per stampare le cose che credono significative. Ma siccome sono tutti legati all’economia della stampa su larga scala, essi alla fine dipendono dal copyright.
Non ci sarà una battaglia drammatica tra l’industria editoriale ed il pubblico che copia, con un climax, un epilogo ed un vincitore netto che si rialza dalla polvere. Vedremo invece – stiamo già vedendo – l’emergere di due flussi paralleli di lavoro creativo: il flusso proprietario ed il flusso libero. Ogni giorno, sempre più persone si aggiungono al flusso libero per loro volontà, per tutti i generi di ragioni. Alcuni gradiscono il fatto che non ci sono guardiani né barriere artificiali. Un’opera può aver successo solo grazie ai suoi meriti ed alla trasmissione orale (passa parola): sebbene niente impedisca alle tecniche tradizionali del marketing di essere usate nel flusso libero, ci sono meno soldi per alimentarle, così qui stanno prendendo maggiore importanza la trasmissione a voce e le reti di revisione alla pari. Altri entrano nel flusso libero come attraversamento dal proprietario, rilasciando una porzione delle loro opere nel dominio libero per pubblicità o per esperimento. Alcuni semplicemente capiscono di non avere alcuna possibilità di successo nel mondo proprietario e giudicano di poter rilasciare ciò che hanno nel pubblico.
Mano a mano che il flusso di materiale liberamente disponibile diventa sempre più grande, il suo senso d’inferiorità lentamente svanisce. Una volta, la differenza tra un autore pubblicato ed uno non pubblicato era che del primo si poteva avere un libro, ma non del secondo. Essere pubblicati significava qualcosa. Aveva un’aura di rispettabilità; implicava che qualcuno avesse giudicato il vostro lavoro e dato un timbro di approvazione istituzionale. Ma ora la differenza tra pubblicato e non pubblicato si sta restringendo. Tra breve, essere pubblicato significherà semplicemente che da qualche parte un editore ha trovato il vostro lavoro adeguato per la stampa su larga scala e possibilmente per una campagna di marketing. Ciò può influenzare la popolarità dell’opera, ma non influenzerà fondamentalmente la sua disponibilità; ci saranno così tante opere “non pubblicate” ma significative, che l’assenza del pedigree della pubblicazione non verrà più considerata automaticamente come un colpo contro un autore. Sebbene il flusso libero non usi il copyright tradizionale, esso usa una firma non ufficiale, il “credito”. Molto spesso le opere vengono copiate e citate con attribuzione – ma i tentativi di rubare il credito di solito vengono rilevati rapidamente e dichiarati pubblicamente. Lo stesso meccanismo che rende facile la copia rende molto difficoltoso il plagio. È molto difficile usare segretamente l’opera di un altro quando una ricerca con Google può trovare rapidamente l’originale. Per esempio gli insegnanti fanno oggi di routine ricerche di frasi rappresentative su Google, quando sospettano che ci sia un plagio nei compiti degli studenti.
Il flusso proprietario non può sopravvivere per sempre di fronte ad una competizione di questo tipo. L’abolizione della legge sul copyright è opzionale; qui la vera forza sono i creatori che scelgono liberamente di rilasciare senza restrizioni le loro opere per copie, perché farlo è nel loro interesse. Ad un certo punto, sarà ovvio [il fatto] che tutta la roba interessante sta andando nel flusso libero e la gente semplicemente cesserà di tuffarsi in quello proprietario. La legge sul copyright potrà formalmente rimanere sui libri, ma in pratica essa si dissolverà, atrofizzata dal disuso.
Oppure possiamo sederci e consentire a questo processo di essere fermato, consentendo ai produttori di incorporare delle “protezioni” hardware che interferiscono con la nostra capacità di copiare legittimamente; consentendo alla lobby del copyright di catturare i nostri legislatori, fino al punto che dovremo guardarci in continuazione dietro le spalle per la polizia del copyright; ed esitando nell’usare il flusso libero al suo pieno potenziale, perché ci hanno raccontato una falsa storia su cos’è fondamentalmente il copyright.
Se scegliamo, possiamo avere un mondo dove concetti come “fuori stampa” o “libro raro” siano non solo obsolete, ma realmente senza senso. Possiamo vivere in un giardino fertile e vibrante di opere che si evolvono in continuazione, create da persone che volevano profondamente renderle disponibili, non opere richieste da una ricerca di mercato dell’editore. Le scuole non sarebbero mai costrette a restare con libri di testo obsoleti a causa del prezzo unitario imposto dagli editori e il tuo computer ti consentirebbe di condividere sempre le canzoni con i tuoi amici.
Un modo per arrivarci è di esaminare il mito del copyright. Copiare non è furto e non è pirateria. E’ ciò che abbiamo fatto per millenni, fino all’invenzione del copyright, e possiamo farlo di nuovo, se non ci intralciamo da soli con gli antiquati residui di un sistema di censura del sedicesimo secolo.
Il contenuto di questo articolo viene rilasciato sotto copyright libero e può essere ridistribuito, citato e modificato senza restrizioni. Se si distribuisce una versione modificata, si prega di correggere le attribuzioni di conseguenza.
Note
[1] Questi eventi si possono leggere in ogni storia del copyright. Una buona risorsa on-line sulle conseguenti implicazioni legali è “Copyright And `The Exclusive Right’ Of Authors” (Il copyright e il “Diritto Esclusivo” degli autori) http://www.lawsch.uga.edu/jipl/old/vol1/patterson.html Journal of Intellectual Property, Vol. 1, No.1, Fall 1993, del professor Lyman Ray Patterson, Pope Brock Professor di Legge all’Università di Georgia, un noto studioso della proprietà intellettuale. La sua descrizione delle origini del copyright è concisa e rivelatrice:
Nella storia anglo americana del copyright l’evento che causò gli eventi formanti del diciassettesimo e diciottesimo secolo fu la Charter of the Stationers’ Company (Carta della Corporazione dei Librai) concessa nel 1556 da Filippo e Maria …. La Carta diede agli Stationers il potere di fare “ordinanze, condizioni e leggi” per la gestione della “arte o mistero della scrittura”, come pure il potere di cercare stamperie e libri illegali ed oggetti, insieme al potere di “requisire, prendere o bruciare i predetti libri e oggetti, e qualsiasi di essi stampato o da stampare in contrasto con la forma di ogni statuto, atto o proclamazione …” Il potere di bruciare i libri offensivi fu un beneficio per il sovrano (un’arma contro le pubblicazioni illegali) ed un vantaggio per gli stationers (un’arma contro la concorrenza). La possibilità di bruciare i libri mostra così la motivazione reale della Carta, assicurare la fedeltà al sovrano degli stationers come poliziotti della stampa in un mondo incerto.
[2] “An Unhurried View of Copyright” (Una visione serena del copyright), Benjamin Kaplan Columbia University Press, 1967, pp. 4-5.
[3] Patterson, in [1], giunge al punto da dichiarare “La caratterizzazione del copyright, così come definito nello statuto, come una protezione dei diritti dell’autore è una delle più grandi bufale della storia.”
[4] Kaplan, p. 6.
[5] Kaplan, pp. 7-9.
[6] “Five Hundred Years of Printing” pp. 218-230, S. H. Steinberg, Penguin Books, 1955, revised 1961
[7] Quando cominciai questo articolo, assunsi che ci volessero alcuni anni per la realizzazione commerciale tali sviluppi, ma avevo torto: il servizio di stampa su richiesta newspaperkiosk.com già esiste ed è funzionante.
[8] Vedi ad esempio www.mp3.com. (Sebbene molte delle offerte sul sito siano nominalmente soggette a copyright, è più che altro un riflesso legale. Le tracce si intendono liberamente scaricabili, ascoltabili e condivisibili – e questo è esattamente ciò che fa la gente.)
[9] Per la descrizione di una tecnica di realizzazione ed una rassegna delle altre, vedi “The Street Performer Protocol and Digital Copyrights” di John Kelsey e Bruce Schneier, all’indirizzo www.firstmonday.dk/issues/issue4_6/kelsey.
[10] Patterson; vedi [1].
Documento originale: questioncopyright.org/promise
Data: 8 gennaio 2004
Traduzione di Comedonchisciotte.net